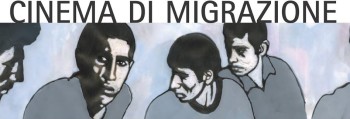 A distanza di tre anni dalla prima edizione della Rassegna “Cinema di Migrazione”, realizzata grazie al contributo e alla solidarietà della Provincia di Roma, siamo a misurare la distanza tra quelle prime ipotesi e convinzioni sui flussi migratori, da e per l’Italia e la mutata realtà sociale, culturale, politica, ma anche antropologica, che in pochissimo tempo ha cambiato il mondo intorno a noi.
A distanza di tre anni dalla prima edizione della Rassegna “Cinema di Migrazione”, realizzata grazie al contributo e alla solidarietà della Provincia di Roma, siamo a misurare la distanza tra quelle prime ipotesi e convinzioni sui flussi migratori, da e per l’Italia e la mutata realtà sociale, culturale, politica, ma anche antropologica, che in pochissimo tempo ha cambiato il mondo intorno a noi.
Dal 2008 al 2010 è mutato profondamente il quadro del problema “immigrazione” e, almeno nelle grandi realtà urbane, è cambiata anche la percezione da parte dei cittadini e dell’opinione pubblica. In primo luogo osserviamo che è diminuita e di molto l’enfatizzazione/drammatizzazione posta dalla destra politica italiana e dalla Lega Nord in particolare. In secondo luogo gli sbarchi a Lampedusa e in Sicilia sono quasi cessati, dal momento che l’immigrazione clandestina, bloccata nei modi che sappiamo sulle coste libiche, ha trovato nuove rotte molto più silenziose e discrete, dai Balcani ai nostri confini orientali.
C’è anche da aggiungere che la crisi economica, che attanaglia dal 2008 tutti gli Stati europei, non lascia più neppure le briciole di un passato benessere alle nuove ondate di immigrazione per necessità provenienti dall’Africa, dall’Asia o dall’Est europeo. Paradossalmente è ripresa anche l’emigrazione verso l’estero, essenzialmente da parte dei giovani diplomati o laureati, che a migliaia cercano in Europa o negli USA quel futuro che in Italia sembra essere loro negato.
E tuttavia sappiamo che Roma e il suo Hinterland hanno visto crescere del 9% nel 2009 la presenza dei cittadini stranieri, i quali tendono a diventare stanziali.
Dal punto di vista quantitativo possiamo ipotizzare che sia diventata più consistente la componente degli immigrati provenienti dall’interno della Comunità europea (Romania, Polonia, Bulgaria) e che stiano crescendo i ricongiungimenti familiari, o le nuove nascite, come attestano anche le accresciute frequenze dei figli di immigrati nella scuola dell’obbligo e, ancora in pochi casi, nelle Università.
Ecco, a questo punto entriamo nel cuore della riflessione che l’iniziativa “Cinema di Migrazione” vuole portare alla attenzione del pubblico.
Noi vogliamo dire che con l’ingresso massiccio nella scuola italiana dei giovani figli di lavoratori immigrati, provenienti dai Paesi più diversi e lontani, è successo qualcosa di nuovo e di estremamente positivo, tale da ribaltare la prospettiva con cui eravamo soliti “vedere” soltanto le emergenze dei fenomeni migratori.
In questi pochi anni che ci separano dai primi sbarchi di massa (in Puglia e in Sicilia) negli anni ’90, i figli di quei migrati sono andati nelle nostre scuole, hanno imparato la nostra lingua e, per quanto era possibile, la nostra cultura; sono ora in mezzo a noi, cittadini italiani di fatto e spesso anche di diritto. Questi ragazzi, chiamati giornalisticamente 2G (seconde generazioni), sono il segno tangibile che è cambiata la qualità dell’immigrazione in Italia, perché essi attestano della loro volontà e dei loro familiari, di “esserci” e di voler restare con noi, nella nuova Italia che si va formando nelle nuove generazioni. Cercheranno la loro strada, come i loro coetanei “nativi” tentando di schivare le insidie del consumismo di massa e del lavoro precario. Aspirano ad un inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, vogliono far valere i loro meriti e lo fanno con una forte determinazione.
 Questi ragazzi sono la migliore garanzia che l’integrazione sta davvero funzionando, anche nei confronti dei loro genitori e delle comunità di provenienza. Infatti, la mutazione antropologica di cui sono portatori mette in discussione tutte le chiusure ideologiche, religiose, culturali, che condizionano così fortemente il mondo degli adulti. I film più belli sui fenomeni migratori sono proprio quelli che evidenziano le fratture e le crisi di identità, come sono effettivamente vissute i tutte o quasi tutte le famiglie che decidono di vivere a cavallo di due mondi diversi, spesso profondamente diversi. Di una certa importanza è anche il fenomeno delle rimesse finanziarie, dalle famiglie emigrate in Italia verso i Paesi di origine. Anche in questo caso, non si tratta soltanto di un trasferimento di risorse, pure rilevantissimo sotto il profilo economico e sociale, ma anche e soprattutto di un ponte che mette in comunicazione culture e valori diversi. Il disagio che si scatena quando si mettono a confronto sistemi di valore fortemente divaricanti può essere certamente devastante (e spesso lo è stato, come lo è tuttora), ma può essere anche estremamente utile per la stabilizzazione delle moderne società multietniche. Possiamo considerare in definitiva i moderni flussi migratori come un sistema di regolazione a vasi comunicanti tra Continenti e Paesi che per millenni sono stati separati nello spazio (geografico) e nel tempo (culturale). La globalizzazione procede a velocità esponenziale, favorita dalla stessa esasperata mobilità dei capitali, delle merci e dell’immaginario multimediale. Si avverte perfino l’esigenza, ogni tanto, di fermarsi, prendere fiato e riflettere: ma che sta succedendo? Dove stiamo davvero correndo tutti quanti?
Questi ragazzi sono la migliore garanzia che l’integrazione sta davvero funzionando, anche nei confronti dei loro genitori e delle comunità di provenienza. Infatti, la mutazione antropologica di cui sono portatori mette in discussione tutte le chiusure ideologiche, religiose, culturali, che condizionano così fortemente il mondo degli adulti. I film più belli sui fenomeni migratori sono proprio quelli che evidenziano le fratture e le crisi di identità, come sono effettivamente vissute i tutte o quasi tutte le famiglie che decidono di vivere a cavallo di due mondi diversi, spesso profondamente diversi. Di una certa importanza è anche il fenomeno delle rimesse finanziarie, dalle famiglie emigrate in Italia verso i Paesi di origine. Anche in questo caso, non si tratta soltanto di un trasferimento di risorse, pure rilevantissimo sotto il profilo economico e sociale, ma anche e soprattutto di un ponte che mette in comunicazione culture e valori diversi. Il disagio che si scatena quando si mettono a confronto sistemi di valore fortemente divaricanti può essere certamente devastante (e spesso lo è stato, come lo è tuttora), ma può essere anche estremamente utile per la stabilizzazione delle moderne società multietniche. Possiamo considerare in definitiva i moderni flussi migratori come un sistema di regolazione a vasi comunicanti tra Continenti e Paesi che per millenni sono stati separati nello spazio (geografico) e nel tempo (culturale). La globalizzazione procede a velocità esponenziale, favorita dalla stessa esasperata mobilità dei capitali, delle merci e dell’immaginario multimediale. Si avverte perfino l’esigenza, ogni tanto, di fermarsi, prendere fiato e riflettere: ma che sta succedendo? Dove stiamo davvero correndo tutti quanti?
Dobbiamo allora soffermarci proprio sulle linee di frattura, sul disagio spiazzante di una “cosa” che la nostra mente non riconosce. Li nasce la riflessione più vera sulla propria identità, della persona, del clan familiare, della comunità cui si appartiene.
La risposta che io personalmente mi sono dato è che l’identità culturale di un popolo può essere definita solo retrospettivamente: Nel tempo presente in effetti l’identità è un processo in divenire, al pari del DNA
genetico il profilo identitario di un popolo è quello che si forma nel precipitato delle vicende etniche, religiose, economiche e sociali. Ma sempre di più in epoca moderna e contemporanea incidono i fattori linguistici, culturali, massmediali.
A livello individuale il percorso identitario dei giovani figli di immigrati si compie in pochissimi anni, che coincidono con quelli dell’adolescenza inquieta (al pari dei loro coetanei “nativi”), mentre in altre fasi della storia delle migrazioni sappiamo (sempre dal Cinema) che la mutazione avveniva nel giro di due o tre generazioni.
Oggi queste autentiche mutazioni antropologiche avvengono sotto i nostri occhi, nel giro di pochi anni.
Il Cinema, e in modo particolare il cinema documentario, ha la facoltà di saper leggere in anticipo tutti questi fenomeni, anche nella loro complessità ed ambiguità.
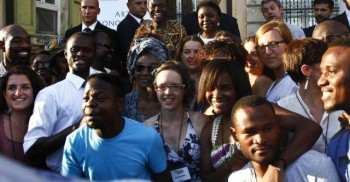 L’Associazione che io dirigo si occupa da molti anni di cultura cinematografica e, come sappiamo, attraverso il Cinema è possibile ricostruire in una certa misura la memoria e la storia collettiva di un popolo. “Cinema di Migrazione” è un progetto a geometria variabile. Abbiamo attivato vari percorsi di riflessione, rivolti in modo particolare ai giovani studenti della scuola media superiore. Uno strumento fondamentale è la filmografia, con la sua capacità di riattivare i flussi di memoria e di coscienza, individuale e collettiva. Un altro strumento di grande efficacia pedagogica è il laboratorio sulla multiculturalità, che noi realizziamo insieme ai docenti all’interno stesso degli istituti scolastici. Infine e non per ultimo, esiste ormai un vero e proprio laboratorio di produzione documentaria, che ha realizzato in pochi anni opere a basso budget, ma estremamente significative sul piano estetico e di grande consapevolezza sotto il profilo etico, grazie al forte impegno dei giovani autori e tecnici impegnati, ma grazie anche alla disponibilità umana dei ragazzi coinvolti, delle loro famiglie, dei docenti che vi hanno partecipato.
L’Associazione che io dirigo si occupa da molti anni di cultura cinematografica e, come sappiamo, attraverso il Cinema è possibile ricostruire in una certa misura la memoria e la storia collettiva di un popolo. “Cinema di Migrazione” è un progetto a geometria variabile. Abbiamo attivato vari percorsi di riflessione, rivolti in modo particolare ai giovani studenti della scuola media superiore. Uno strumento fondamentale è la filmografia, con la sua capacità di riattivare i flussi di memoria e di coscienza, individuale e collettiva. Un altro strumento di grande efficacia pedagogica è il laboratorio sulla multiculturalità, che noi realizziamo insieme ai docenti all’interno stesso degli istituti scolastici. Infine e non per ultimo, esiste ormai un vero e proprio laboratorio di produzione documentaria, che ha realizzato in pochi anni opere a basso budget, ma estremamente significative sul piano estetico e di grande consapevolezza sotto il profilo etico, grazie al forte impegno dei giovani autori e tecnici impegnati, ma grazie anche alla disponibilità umana dei ragazzi coinvolti, delle loro famiglie, dei docenti che vi hanno partecipato.
Sono nate in questo modo opere significative, presenti nei principali Festival del documentario a tuttora in circolazione nel mondo scolastico, quali: Sei del mondo (2006), Welcome Bucarest (2007), Fratelli d’Italia (2009).
Altre produzioni partiranno nel 2011 ed andranno ad aggiungersi al già rilevante numero dei film di documentazione, nati per dare volto e voce alle tante storie di migrazione di cui siamo testimoni, nel nostro tempo.
E’ il “Cinema della Realtà”, in cui ci siamo formati e in cui crediamo, come una delle vie (forse la via maestra) per comprendere quale sia il nostro mestiere di uomini e di cittadini: saper osservare per poter cambiare la qualità dei rapporti tra le persone. Il Cinema è uno sguardo sul mondo, ma è anche uno sguardo rivolto all’interno della nostra coscienza, della nostra memoria individuale e collettiva. Il Cinema è la storia del mondo.
Roma, Gennaio 2011
Giorgio Valente

